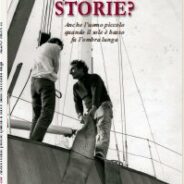Descrizione
Una bambina esce di casa per raggiungere la spiaggia e dare molliche ai passeri. Un giovane in licenza torna a casa per Natale e nessuno riesce a cogliere il segreto che porta con sé. Una lettera scritta dopo molti anni di assenza rivela la labilità dei confini.
Alisei non è semplicemente una raccolta di racconti. E’ qualcosa di più.
E’ la narrazione avvincente e spietata di un quotidiano che da ordinario si fa straordinario, di un gesto semplice che perde, d’un tratto, il suo assetto naturale e deraglia, tanto da mutare la collocazione apparente delle cose e degli eventi per situarli altrove.
In queste storie veniamo catapultati davanti all’occhio di una telecamera guidata in modo magistrale, che non svela mai la direzione della storia, ma la sottende fin dalle prime battute.
Usando strumenti affilatissimi quali la potenza della scrittura, la ricerca interiore, l’attenzione per il dettaglio – quello che Roth definisce la macchia umana- Piera Ventre, con questo libro d’esordio, si presenta ai lettori con una competenza narrativa da grande scrittrice.
Piera Ventre
Nata a Napoli, Piera Ventre vive a Livorno dove lavora come logopedista e assistente alla comunicazione. Da bambina, delle sorelle March, trovava Meg troppo responsabile, Amy vaporosa e Beth timida e fragile. Delle sorelle March, lei avrebbe voluto essere Jo. Per questo, scrive.
http://biancamara.wordpress.com/
FORTUNE
Me lo diceva sempre, mia madre. Vali niente. Guardati Fortune, diceva, Sembri uno spaventapasseri con queste treccine ispide come le stoppie del mais.
Ingollava qualche sorso di tè annacquato e rideva.
Fortune. Il nome che aveva scelto per me sembrava uno scherzo. Ma come si fa, mi chiedo ora, a chiamare qualcuno così? Quando la signora Higgins mi mise per la prima volta tra le sue braccia secche, ripulita alla bell’e meglio dal sangue e dal muco, lei, mia madre, disse Questa bambina è più brutta d’una scimmia denutrita.
Ovviamente non sono cose che io possa ricordare. Né tantomeno la signora Higgins, un muffin ripieno di buoni sentimenti e di pietà universale fino a che ha avuto abbastanza fiato per respirare, si sarebbe mai sognata di confessarmi quella frase che le arrivò, come un bastone infuocato, sulla schiena ricurva.
Fu mio padre, poco prima che il fegato gli scoppiasse come un palloncino troppo gonfio, a raccontarmelo. E non so neppure bene perché lo fece, visto che a quel tempo non aveva più alcuna importanza.
Credo che decise di chiamarti Fortune, disse mentre era steso nel letto di ferro dell’ospedale della contea di Tallapoosa, Perché pensava fosse di questo che tu avessi bisogno. Di fortuna.
Mio padre non c’era quasi mai quando lei mi diceva che valevo niente. E, se c’era, si limitava a dire, Grace, lasciala in pace.
Avrebbe fatto lo stesso se Timmy si fosse divertito a tirare la coda al cane.
Non era cattivo mio padre, ma nemmeno gli piaceva accendere tizzoni. Voleva che le cose filassero lisce. Che il bollitore fosse colmo di caffè, che la sfoglia del pasticcio di carne fosse croccante e che la domenica i vestiti fossero lindi e stirati per avere un aspetto dignitoso durante il sermone del reverendo Jones. Che tutti in paese pensassero bene di noi, della famiglia Maud.
Guardati, diceva mia madre, sorridendo il suo sorriso sghembo, prima che uscissimo di casa, Guardati, Fortune, sembri una gruccia sbilenca.
Sul mio corpo filiforme e minuto, qualsiasi vestito si appoggiava senza grazia, le gonne pendevano tutte da un lato, le camicette assumevano le grinze di un sacco di juta vuotato dai fagioli.
Vali niente, Fortune, urlava, quando correndo nel cortile appresso a qualche gatto, finivo stesa per terra, le ginocchia sbucciate, i gomiti pieni di graffi. Timmy, lui sì che sa quel che vuole, diceva mia madre, Timmy è la mia copia spiccicata, saprebbe cavare gli occhi ai ragni, sfilare la pelle ai crotali.
Mi nutriva, mia madre. Mi riempiva la tazza di porridge, la mattina, e di latte, un mucchio di latte per far crescere le mie ossa stentate. Pettinava i miei capelli fini, gambi di fieno secco, e li legava con nastri colorati. Si prendeva cura di me, tutto sommato, come avrebbe fatto una giumenta col suo puledro. Poi mi dava una pacca sul sedere e diceva, Va’, sei pronta, piccola scimmietta spelacchiata.
A tutti gli effetti posso mica dire che sia stata una madre cattiva. Ero io a sbagliare il più delle volte. Era la mia faccia. Una faccetta pallida e picchiettata di efelidi, la superficie d’un pane al sesamo scotto, a non meritare più che quello.
La sentivo, mia madre, quando chiacchierava in cucina con Betty Finner davanti al vassoio di biscotti appena sfornati.
Fortune, non è una cattiva figliola, diceva, Ma vale un penny bucato. Qualsiasi cosa faccia, non è capace. Meno male che c’è Timmy, diceva, il mio Timmy, lui sì, si butterebbe nel fuoco senza bruciarsi.
E quando Timmy, invece che nel fuoco, si buttò nelle acque dello Swindall Lake, per non farvene più ritorno, le cose non fecero che mettersi peggio per tutti noi, per quello che restava della famiglia Maud.
Il reverendo Jones disse parole molto toccanti al funerale di mio fratello. Mio padre si prese tutte le pacche sulle spalle con dignità e fermezza, affinché tutti potessero pensare bene di noi. Di come eravamo stoici. Di come il destino ci avesse fatto un così brutto tiro e, malgrado ciò, il bollitore avrebbe continuato a essere colmo di caffè, i campi sarebbero stati arati, le pastinache cavate dalle zolle al momento giusto e i nostri vestiti lindi e stirati per la funzione della domenica mattina.
Mia madre, però, non la pensava esattamente così.
Cominciai a capire che qualcosa non andava quando, nel pettinarmi, smise di dirmi qualsiasi cosa. Neppure un piccolo sospiro che le uscisse sotto forma di Fortune, sembri una ramazza agghindata con un nastro rosa.
Se era seduta sul dondolo sotto al portico, fingevo perfino di inciampare e cascavo lunga per terra, sperando che la sua voce formulasse il solito Vali niente.
Ma lei restava muta. Gli occhi persi chissà su quale punto del cielo e nemmeno si accorgeva che ero riversa sulla ghiaia.
Quel giorno che tornai da scuola e vidi la macchina del ranger parcheggiata sul vialetto pensai subito a mio padre. Che qualche pazzo ubriacone gli avesse puntato contro un Winchester e avesse fatto fuoco scambiandolo per un lupo delle praterie.
Invece mio padre era nel tinello, la faccia tra le mani e il capo chino che pareva osservare gli stivali lucidi del ranger Collins dalle suole incrostate di fango.
Fortune, disse senza rivolgermi uno sguardo, Piccola, va’ nella tua stanza.
Non piangere, mi sussurrò la signora Winnicott, qualche giorno dopo, mentre le funi attorno alla cassa con dentro il corpo di mia madre, sembravano venire inghiottite dalle grosse zolle di terra grassa.
Mio padre fissava la fossa che ingoiava il bollitore colmo di caffè, i nostri vestiti lindi e stirati, noi, insomma, la famiglia Maud.
Non piangere, mi ripeté la signora Winnicott, passando una mano grassoccia sui miei capelli stopposi.
Ma io non piangevo. Mai stata capace di fare niente, io.
Per fortuna, neanche di piangere.